la comunicazione olfattiva
Ancora prima di essere “animali pensanti”, noi umani sperimentiamo attraverso il corpo la nostra esistenza e trasformiamo «il flusso incessante delle cose [...] in immagini, suoni, odori, tessiture, colori, paesaggi ecc.» dando forma a significati precisi (Le Breton 2006). Tutte le modalità di senso possono essere considerate «informatori per l’anima» tramite i quali interagiamo con il mondo, raccogliendo informazioni utili che il nostro cervello interpreta immediatamente per organizzare una reazione. I sensi definiscono i limiti della nostra coscienza e della nostra conoscenza inserendoci nel mondo in un modo unico: come dei filtri, trattengono solo ciò che biologicamente e culturalmente si rivela necessario all’esistenza specificamente umana.
E questo vale per ogni specie animale la cui forma di vita è ‘costretta’ in un universo fenomenico peculiare e per certi versi esclusivo. Con una sola differenza: le varie specie animali nascono con un equipaggiamento sensoriale già definito geneticamente, mentre nell’uomo la diversa educazione culturale, una precisa esperienza e la personalità consentono di arricchire o comunque di esercitare in misura diversa le possibilità percettive di cui egli è dotato biologicamente.
Ogni specie vive e percepisce un diverso ambiente stabilendo con esso una relazione regolata dalle possibilità apertele dalle sue attrezzature neurosensoriali. Il mondo percepito da una determinata specie è solo di quella specie, diverso da qualsiasi altro e
limitato alle proprietà dell’ambiente circostante accessibili ai suoi organi di senso e dimostratesi evolutivamente utili alla sua sopravvivenza. I molteplici segnali che noi esseri umani non siamo in grado di udire, odorare, gustare o toccare, perché al di fuori del nostro specifico orizzonte percettivo, sono comunque reali e salienti per altre specie.
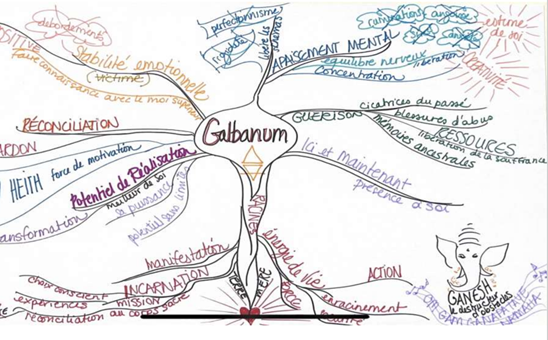
Di conseguenza, anche i sistemi di comunicazione di cui dispongono le diverse specie animali saranno commisurati alle peculiarità dell’ambiente soggettivo della specie che li possiede. La nostra vista è indubbiamente più debole di quella di un’aquila, ma le nostre mani sono di una stupefacente sofisticatezza, rivelatasi evidentemente più necessaria per la nostra sopravvivenza e per la nostra cognitività; il nostro udito non è straordinario come quello di un pipistrello, ma i suoi limiti percettivi ci hanno permesso di sviluppare la parola e di caratterizzarci come gli unici animali linguistici.
In un certo senso, afferma Diane Ackerman (1990), «viviamo al guinzaglio dei sensi: se da un lato i sensi allargano i nostri confini, dall’altro ci limitano e ci vincolano, ma in che modo meraviglioso!». Se le diverse specie animali sono equipaggiate grosso modo di un corredo sensoriale comparabile, nel senso che occhi, orecchie, naso, senso dell’equilibrio,
tattilità e papille gustative presentano delle similitudini, tuttavia in ogni specie le differenze nella sensibilità e nel campo di applicazione dei segni sono enormi e per di più specie-specifiche. I pesci, ad esempio, a eccezione di qualche specie abissale, non sentono e hanno una vista poco sviluppata: nondimeno, navigando nelle profondità oscure delle acque, per sopravvivere vengono sorretti da segnali tattili (percepiti sotto forma di vibrazioni, cioè di rumori), olfattivi ed elettrici.
Pur vedendo perfettamente anche al buio, i gatti di giorno hanno una visione praticamente incolore. I pipistrelli sono dotati di un orecchio finissimo grazie al quale possono navigare al buio. Il loro apparato uditivo è capace di percepire gli ultrasuoni e di geolocalizzare con precisione le prede e gli ostacoli anche nell’oscurità, ma non è sensibile alla voce umana, per loro del resto irrilevante. I cani hanno un olfatto ipersviluppato e oltremodo raffinato, all’incirca alcune centinaia di volte più sensibile di quello umano: i cani da valanga sono capaci, per esempio, di localizzare una persona sepolta sotto la neve a diversi metri di profondità. Ma è anche vero che noi umani, pur essendo considerati microsmatici, siamo gli unici animali in grado, per esempio, di apprezzare lo squisito profumo dei fiori, di combinare sostanze odorose per creare essenze e profumi, di degustare e di descrivere un vino o un cibo avvalendoci della competenza del naso. Nonostante, quindi, le analogie funzionali e anatomiche dei sistemi sensoriali, nell’universo animale i mondi sensibili da una specie all’altra non coincidono.
Come qualsiasi altra modalità sensoriale, e in quanto meccanismo di trasmissione d’informazioni, la percezione degli odori può essere considerata un linguaggio non verbale mediante il quale acquisiamo conoscenze sull’ambiente chimico, regoliamo i nostri comportamenti sociali e agiamo, in modo più o meno consapevole, sul comportamento di un individuo (in genere cospecifico).
Anche il nostro olfatto s’inscrive nel registro della comunicazione chimica, impiegata dagli organismi più diversi, a partire da quelli unicellulari come i batteri fino alle formiche, alle api, alle farfalle, ai porcospini, ai salmoni, ai cani da caccia e a numerose altre specie animali. Abituati ad attribuire molta importanza alla vista e all’udito e a considerare l’odorato un senso primitivo e quasi superfluo, noi umani abbiamo difficoltà persino a comprendere perché un animale, pur dotato di una buona vista, preferisca ricorrere al naso. Tuttavia è proprio questo senso a svolgere un ruolo dominante in natura, al punto che numerose specie animali, ad esempio i pesci, la cui vista è fortemente limitata dal mezzo liquido, non riuscirebbero
mai a cavarsela senza il loro fiuto. La comunicazione olfattiva insieme a quella tattile è il sistema semiotico più primitivo e anche il più fondamentale. Attiva ventiquattro ore al giorno, per gli organismi più elevati è indispensabile per la vita, altrimenti impossibile.
Tra i più usati nel mondo animale, soprattutto dagli insetti e da tutti gli invertebrati, il canale chimico è comunque presente in tutti gli organismi, uomo incluso. I batteri
comunicano esclusivamente attraverso questa via, e anche le piante interagiscono fra loro e con gli animali (in particolare con gli insetti, ma anche con l’uomo) attraverso gli aromi. Un gruppo di scienziati americani e israeliani ha scoperto che persino l’atto del concepimento è il frutto di una seduzione di tipo chimico: l’incontro tra l’ovulo maturo e lo spermatozoo è reso possibile dalla dispersione di molecole odorose nell’organo sessuale, le quali segnalerebbero agli spermatozoi la presenza dell’ovuloguidandoli fino ad esso. La prova che il concepimento è frutto di una comunicazione chimica è stata fornita nel corso di interventi di fecondazione artificiale attraverso il prelievo del liquido che circonda l’ovulo divenuto
maturo e liberato dal follicolo dell’ovaio. Durante un esperimento si è visto come una minuscola goccia di questo liquido introdotta in una provetta in cui sono presenti cellule sessuali maschili basti ad attirarle tutte in quella direzione e a farle arrestare solo quando hanno raggiunto il punto in cui è stata introdotta la goccia.
È suggestivo scoprire solo oggi che sin dalla notte dei tempi l’arma seduttiva usata dalle donne per sottolineare la propria femminilità e attrarre un uomo (cioè un profumo) sia la stessa impiegata dall’ovulo per condurre verso di sé gli spermatozoi: solo uno di essi sarà sedotto dal “profumo di vita’, i feromoni. I messaggi olfattivi hanno poi un carattere fortemente imperativo che non lascia possibilità di scelta, incitando fermamente a una certa condotta. «I messaggi chimici sono così completi e specifici – afferma E.T. Hall (1966) – che si può dire che superino di gran lunga, per organizzazione e complessità, qualsiasi sistema di comunicazione che l’uomo abbia mai creato, compresi sia il linguaggio in tutte le sue forme – parlata, scritta, o matematica – che l’insieme di operazioni compiute su vari generi di informazioni dai più moderni computer». I messaggi chimici hanno altresì un carattere persistente e duraturo, nel senso che i segnali possono protrarsi anche per lunghi periodi di tempo e in assenza dell’emittente: in genere gli odori – almeno per quanto concerne l’uomo – si
ricordano molto più a lungo delle immagini, e questa è la proprietà dell’olfatto che maggiormente influisce sul comportamento umano.
A tutti è noto il potere esercitato dalla musica e dalle immagini sui nostri sensi e quindi sulla nostra psiche, ma non può certo dirsi lo stesso per gli odori, il cui potere persuasivo è ai più sconosciuto. L’olfatto inoltre sfugge al controllo delle regole che governano gli altri sistemi sensoriali, connotandosi come il più emotivo e il meno controllabile razionalmente. L’apparente debolezza del naso, il suo essere più diretto (per la sua azione immediata sul sistema nervoso), più intuitivo e specialmente più evocativo degli altri sensi (le memorie olfattive sono le più persistenti), è in realtà il suo punto di forza. Poeti e scrittori in tutti i tempi hanno speculato sulle sensazioni emotive suscitate dagli odori e raccontato come questi provochino ampi voli della memoria. Il linguaggio degli odori agisce su un canale meno frequentato – quello emotivo – e perciò stesso più ricettivo e immediato, una peculiarità che
certamente va sfruttata nella comunicazione: questo lo rende molto più eloquente e più convincente delle parole, motivando l’acquisto di un prodotto in modo più incisivo e seducente.
Appellandosi proprio a questo potere straordinario degli odori P. Süskind, autore del noto romanzo Il profumo (1985), una geniale celebrazione dell’olfatto, scrive che «il profumo ha una forza di persuasione più convincente delle parole, dell’apparenza, del sentimento e della volontà». In fin dei conti, al profumo non si può resistere e non v’è modo di opporsi alla sua forza di penetrazione. Sono queste le ragioni che maggiormente hanno contribuito al successo delle scelte olfattive quale nuova frontiera nel campo del marketing.
