Cos’è un odore dal punto di vista fisico e chimico?
Da cosa dipende la sensazione olfattiva?
E perché alcune sostanze emanano odore e altre no?
Interrogativi complessi che a tutt’oggi non hanno ricevuto una spiegazione univoca e pienamente soddisfacente. Il termine “odore” può riferirsi a due cose:
La sensazione olfattiva: ciò che percepiamo quando annusiamo qualcosa.
La fonte dell’odore: l’oggetto o la sostanza che produce quel profumo.
Questa definizione è un po' ambigua perché l'esperienza dell'olfatto è incerta. Quando possiamo vedere e sentire chiaramente la fonte di un odore, di solito associamo l’odore direttamente a quella fonte. Ma quando la fonte dell'odore non è visibile o l'odore è molto debole, possiamo iniziare a dubitare se ciò che abbiamo percepito sia reale o meno.
Interrogativi complessi che a tutt’oggi non hanno ricevuto una spiegazione univoca e pienamente soddisfacente. Il termine “odore” può riferirsi a due cose:
-
- La sensazione olfattiva: ciò che percepiamo quando annusiamo qualcosa.
- La fonte dell’odore: l’oggetto o la sostanza che produce quel profumo.
Questa definizione è un po' ambigua perché l'esperienza dell'olfatto è incerta. Quando possiamo vedere e sentire chiaramente la fonte di un odore, di solito associamo l’odore direttamente a quella fonte. Ma quando la fonte dell'odore non è visibile o l'odore è molto debole, possiamo iniziare a dubitare se ciò che abbiamo percepito sia reale o meno.
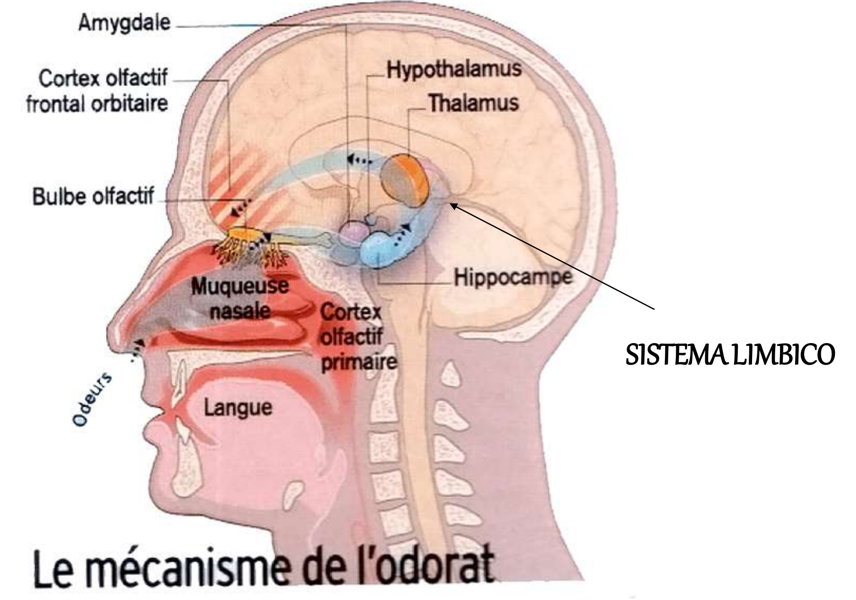
Una sensazione olfattiva ha luogo quando una data sostanza (odorante) agisce su recettori specifici – allo stesso modo in cui le variazioni della pressione atmosferica diventano suoni solo quando sono percepiti dall’orecchio. L’odore nasce così dall’incontro delle molecole odoranti con i recettori molecolari (che sono poi delle proteine) situati nell’organo nasale.
Questa sensibilità di tipo molecolare si attiva però solo se si verificano certe condizioni fisiche:
- volatilità (in ambiente aereo)
- solubilità (in ambiente liquido).
Indipendentemente dall’ambiente che li veicola, gli odori obbediscono poi a leggi fisiche: l’alta temperatura favorisce la diffusione delle molecole odorose e il loro accesso ai recettori olfattivi e l’aumento della pressione atmosferica rende odorosi certi composti chimici, altrimenti inodori, come l’elio, usato nelle immersioni sottomarine. Ma nella determinazione di un odore intervengono ancora altri fattori importanti: la capacità di stabilire legami intermolecolari con la membrana delle cellule olfattive (in genere maggiore nelle molecole di grossa taglia, meno volatili ma più ricche di legami intermolecolari, laddove quelle più piccole hanno invece maggiore volatilità e legami più deboli con i recettori); e la solubilità delle molecole nell’acqua e nei grassi, necessaria per entrare in contatto con il muco, per poi disciogliersi nella membrana dei recettori olfattivi (di natura lipidica) e legarsi infine con le proteine che compongono sia la mucosa olfattiva sia i recettori. Ecco perché le sostanze dotate di maggiore solubilità nei grassi sono più odorose.
Altrettanto importante, ma non meno problematico, è cercare di stabilire da quali condizioni chimiche dipenda una sensazione olfattiva. La relazione tra le caratteristiche chimiche di una sostanza e il particolare odore da essa prodotto non è facile da determinare: sostanze con una struttura molecolare simile possono dar luogo a odori molto diversi (ad esempio il pompelmo mercaptano [C10H18S] odora di pompelmo, mentre l’alfa-terpineolo, con una formula chimica vicina [C10H18O] odora di aghi di pino), mentre sostanze chimicamente differenti possono produrre odori simili. Ad esempio: L’odore di vaniglia può essere ottenuto da diverse fonti. La vaniglia naturale deve il suo profumo alla vanillina, ma la vanillina può essere sintetizzata da fonti chimiche diverse, come il lignina da legno o il guaiacolo da petrolio, e in molti casi non proviene direttamente dalle bacche di vaniglia. Tuttavia, il profumo risultante può essere molto simile.
Fino ad oggi nessuna caratteristica chimica è riuscita a spiegare questi fenomeni in maniera del tutto esaustiva. Facciamo quindi riferimento a due diverse teorie: la prima è quella stereochimica avanzata da J. Amoore alla fine degli anni Cinquanta e successivamente perfezionata. Sarebbero la forma geometrica e la dimensione della molecola a determinarne un particolare odore, adattandosi a quelle dei recettori olfattivi e scatenando l’impulso nervoso che viene trasmesso al cervello. In breve, l’odore è forma, e ogni molecola risulterebbe dotata di curve, gobbe e scanalature irriproducibili. Quest’ipotesi suggerisce l’immagine di una semplice relazione complementare basata sul principio della particolare chiave che corrisponde a una particolare serratura: se la forma discoidale, cuneiforme o sferica delle molecole combacia con i recettori corrispondenti allora si avrà l’odore muschiato, di menta o di canfora e così via. Amoore aveva ipotizzato l’esistenza di sette classi di odori primari da cui deriverebbero per combinazione tutti gli altri odori.
- Floreale
Esempi: Rosa, gelsomino, lavanda.
- Fruttato
Esempi: Fragola, mela, limone.
Speziato
Descrizione: Odori associati alle spezie e ai condimenti.
Legnoso
Descrizione: Odori che ricordano il legno e la corteccia.
Esempi: Cedro, sandalo, pino.
Resinoso
Descrizione: Odori simili alla resina o alla gomma.
Esempi: Incenso, pino resinoso, benzoino.
Medicinale
Descrizione: Odori associati a medicinali o sostanze chimiche.
Esempi: Eucalipto, mentolo, camphor.
Pungente
Descrizione: Odori forti e irritanti, spesso associati a sostanze chimiche o di decomposizione.
Esempi: Ammoniaca, zolfo, acido acetico.
Queste categorie sono utili per comprendere e classificare le diverse percezioni olfattive in modo sistematico. Amoore ha utilizzato questo schema per facilitare lo studio e la comprensione dei complessi profili aromatici e per migliorare la comunicazione nel campo della ricerca olfattiva, tuttavia questa teoria ha un limite: l’esistenza di molecole praticamente identiche ma con odori totalmente differenti, e di molecole diversissime tra loro con odori simili, non quadra con questa teoria.
La grande diversità di molecole odoranti – il fatto che la loro forma, per esempio, possa cambiare in relazione al tipo e al numero di legami intermolecolari instaurati nei recettori e alla polarità della molecola (orientamento) – rappresenta poi un altro problema per la teoria stereochimica, che non riesce a spiegare un gran numero di sensazioni olfattive. E di fatto resta ancora un mistero cosa accada di preciso tra le molecole e i recettori, cioè come un odorante stimoli una cellula sensoriale e come questa sia fatta esattamente. Una teoria più innovativa riconduce la sensazione dell’odore alla vibrazione delle molecole delle sostanze odoranti, anziché, come affermava la teoria stereochimica, alla loro forma.
Riproposta da una decina d’anni dal biofisico italo-francese Luca Turin, la teoria vibrazionale in realtà era stata avanzata intorno al 1930 dal chimico inglese M. Dyson. Quest’ultimo aveva ipotizzato che, come uno spettroscopio, il naso umano ci consentisse di riconoscere subito gli aromi presenti in una molecola e per di più di distinguere una molecola dall’altra. Ad ogni odore corrisponderebbe una lunghezza d’onda capace di provocare nel nostro cervello la sensazione del profumo o del puzzo, analogamente al modo in cui l’orecchio è stimolato dalle vibrazioni dell’aria (trasformate in suoni) e l’occhio dalle onde elettromagnetiche (trasformate in colori).
Benché ancora discussa, questa teoria ha ricevuto conferme da studi recenti: per Marshall Stonham (Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'University College di Londra) "questo meccanismo sembra molto fantasioso nel contesto della biologia, ma è perfettamente conosciuto e documentato in sistemi fisici inerti". E per una buona ragione: è alla base della spettroscopia ad effetto tunnel, una tecnica inventata dai fisici per identificare le molecole attraverso il loro spettro vibrazionale.
Funziona così nell'olfatto?
Marshall Stonham e i suoi colleghi hanno preso in considerazione questa proposta nel 2007. "Ci siamo chiesti se ci fossero obiezioni fisiche a questo meccanismo ... La nostra conclusione è che il modello sembra robusto", riassume il fisico. Se effettivamente l’olfatto funzionasse grazie alla vibrazione delle molecole, esso avrebbe molto in comune con la vista e con l’udito.
Ai fini di comprendere meglio la questione è importante citare anche i lavori di Richard Axel e Linda Buck, del centro Fred Hutchinson di Seattle, premi Nobel nel 2004 per la Medicina e la Fisiologia: i due ricercatori hanno scoperto che alla base della percezione della grande varietà di odori percepibili dalla specie umana, c’è un insieme di circa mille geni. Questi geni controllano un numero equivalente di recettori olfattivi, tutti diversi, collocati su cellule di una piccola area dell’epitelio nasale. Questi mille geni deputati allo sviluppo dei recettori olfattivi corrispondono a circa il 3% dell’intero genoma umano. Il 3% denota un’importanza enorme: il nostro DNA non concede agli altri sensi altrettanta attenzione, nemmeno alla vista e all’udito messi assieme!
